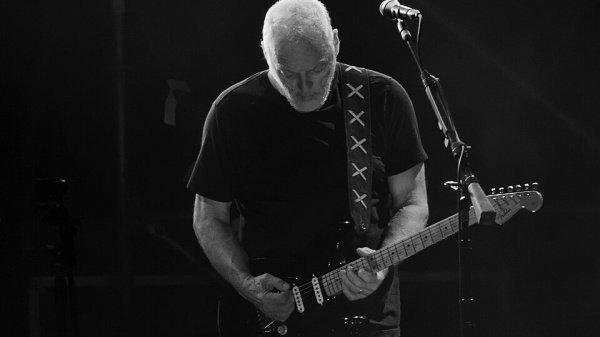Tre canzoni nate per caso

10 gennaio 2026 alle ore 09:37, agg. alle 11:24
Tre canzoni diventate memorabili senza essere cercate: tra soundcheck, prove di amplificatori e intuizioni catturate per caso da produttori lungimiranti.
Tra un amplificatore da provare, un soundcheck distratto o una registrazione “rubata”, a volte la musica migliore nasce quando la testa è altrove. Quando un artista, un musicista o una band suonano senza pensarci e senza l’urgenza di creare qualcosa di memorabile, può emergere una leggerezza istintiva, un pilota automatico capace di generare intuizioni preziose.
Da Lenny Kravitz ai Van Halen, passando per i primi The Cure, abbiamo messo in fila tre brani nati quasi per caso e diventati, proprio per questo, incredibilmente autentici.
"Cosa diavolo hai suonato?"
Per gli appassionati di chitarra, per i musicisti e per chi frequenta la musica più tecnica, Paul Gilbert è un riferimento assoluto. Prodigio dell’iper tecnicismo neoclassico metal negli anni Ottanta con i Racer X, rock star negli anni Novanta con i Mr. Big, oggi è un artista maturo che continua a pubblicare ottima musica strumentale. Ma più dei dischi e delle classifiche, a colpire è un aneddoto che Gilbert racconta spesso, con disarmante semplicità. Dice che quando imbraccia la chitarra per verificare se lo strumento è regolato correttamente, se l’amplificatore risponde come dovrebbe o se la pedaliera è cablata nel modo giusto, non sta pensando a cosa suona. È concentrato solo sull’ascolto, sul suono, sulla risposta tecnica dell’attrezzatura. Eppure, puntualmente, qualcuno intorno a lui gli fa notare: “Paul, hai appena suonato qualcosa di incredibile. Cosa diavolo era?”. La sua risposta è quasi sempre la stessa: non lo sa. Non ne è consapevole. Perché non stava suonando per creare, stava solo ascoltando e facendo viaggiare le mani. Da questa riflessione nasce anche la nostra. Siamo abituati a raccontare la nascita delle grandi canzoni come un atto quasi solenne: l’artista che si isola, si concentra, razionalizza l’ispirazione e la traduce in forma, attingendo consapevolmente a tutto il proprio bagaglio tecnico, culturale ed emotivo. È un’immagine rassicurante, ordinata, che restituisce l’idea di un controllo totale del processo creativo. Ma non sempre la musica funziona così. Anzi, molto spesso accade esattamente il contrario. Esistono momenti in cui la testa è occupata altrove, lontana da qualsiasi intento artistico. Momenti tecnici e pratici: un soundcheck, una prova di strumentazione, il test di una chitarra, di un amplificatore o di un pedale appena arrivato. Situazioni in cui l’unico obiettivo è verificare che tutto funzioni, che il suono sia a posto, che i monitor rispondano. In quei frangenti non c’è alcuna ansia da prestazione, nessuna pressione creativa, nessuna aspettativa da soddisfare. Ed è proprio lì che, paradossalmente, può succedere qualcosa di speciale. Le mani si muovono in automatico, libere dal giudizio e dalla volontà di “scrivere bene”. Il controllo si allenta e lascia spazio a un flusso istintivo fatto di memoria muscolare, esperienza e musica sedimentata. Non è un caso se tante canzoni memorabili nascono così: da un riff distratto, da una jam senza scopo, da un momento di leggerezza assoluta. Che si tratti di un soundcheck, di una prova di strumentazione o di una registrazione catturata quasi per caso mentre un musicista ha la testa altrove, il risultato non cambia: a volte la musica migliore nasce quando non la stai cercando. Da qui parte la nostra selezione.
Fly Away – Lenny Kravitz (FIVE, 1998)
"Fly Away" non doveva nemmeno finire su 5, e invece è diventata uno dei brani più celebri della carriera di Lenny Kravitz, vincendo anche un Grammy nel 1999. La sua nascita è quanto di più distante ci sia da un’idea di scrittura pianificata. Lenny Kravitz sta semplicemente provando un amplificatore, cercando di capirne il suono. Nessuna intenzione creativa, solo qualche accordo buttato lì, quasi per gioco, peraltro nemmeno perfettamente in tonalità. Eppure, in quel cazzeggio tecnico, qualcosa scatta. Quel riff grezzo e immediato sembra avere un potenziale particolare, tanto da convincerlo a fermare tutto e chiedere al fonico di piazzare un microfono davanti all’ampli e registrare. Da lì il passo è breve: su quel frammento nascono un groove di batteria e basso, poi una melodia vocale e un testo. In origine "Fly Away" non era nemmeno destinata all’album, ma la forza di quell’idea spontanea finisce per imporsi. Il risultato è un brano costruito su un equilibrio perfetto tra groove, suoni vintage e sensibilità moderna, capace di trasformare un’intuizione nata quasi per sbaglio in un successo globale.
Spanish Fly – Van Halen (VAN HALEN II, 1979)
La storia racconta che Eddie Van Halen, una sera a casa del produttore Ted Templeman, dopo qualche bicchiere di troppo, si fosse messo a giocare su una chitarra acustica. Colpito da ciò che stava succedendo, Templeman decide di non lasciar cadere quel momento: registra quasi a insaputa di Eddie i capricci improvvisati di estro e virtuosismo che il chitarrista snocciola giocosamente sulla chitarra. Sono una gemma e vanno inseriti nel disco in lavorazione. In poco meno di un minuto Eddie dà vita a una prova di virtuosismo impressionante, sostenuta però da una musicalità e da un groove tali da trasformare quella che poteva restare una semplice dimostrazione di abilità in una vera perla musicale, compiuta e credibile. "Spanish Fly" è un volo pindarico di sola chitarra, istintivo e libero, che si incastra tra i solchi incandescenti dell’hard rock di VAN HALEN II, secondo album della band pubblicato nel 1979.
Foxy Lady – The Cure (THREE IMAGINARY BOYS, 1979)
Siamo nel 1979 e i The Cure stanno lavorando al loro disco di debutto, THREE IMAGINARY BOYS. Non hanno ancora vent’anni e il controllo artistico del progetto è saldamente nelle mani del produttore Chris Parry, che supervisiona le sessioni ai Chestnut Studios di Londra. La band, in realtà, non avrebbe alcuna intenzione di inserire una cover nell’album. Eppure, durante i soundcheck, c’è un brano che i Cure suonano sempre: "Foxy Lady" di Jimi Hendrix. È il pezzo che usano per sentirsi tra loro, per verificare che i suoni funzionino, che la strumentazione risponda, che l’equilibrio in sala sia quello giusto. Un rito tecnico, privo di qualsiasi ambizione artistica, che viene riproposto anche in studio con lo stesso spirito leggero e inconsapevole. In questa versione, tra l’altro, Robert Smith non canta nemmeno: al microfono va il bassista Michael Dempsey, ulteriore segnale di quanto quel momento fosse lontano da qualsiasi senso di responsabilità creativa. Proprio per questo, Parry coglie l’attimo: ne riconosce l’energia, la veracità, e decide non solo di registrarla, ma di inserirla nel disco. Ne esce una "Foxy Lady" stralunata, sgangherata, in piena estetica post-punk. I Cure non sono ancora dark: qui sembrano piuttosto una band new wave eccentrica, più vicina ai Devo o ai Cars più obliqui. E all’inizio del brano si sentono persino i musicisti che provano i suoni e parlano tra loro. Un altro frammento di spontaneità catturato quasi di nascosto che fotografa il suono nuovo, quasi inconsapevole, di new wave e post punk